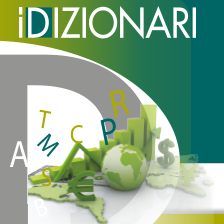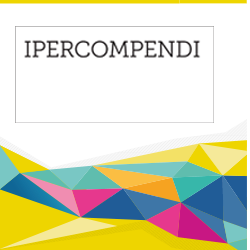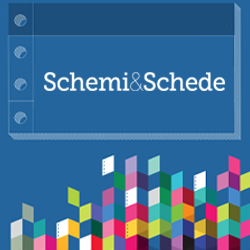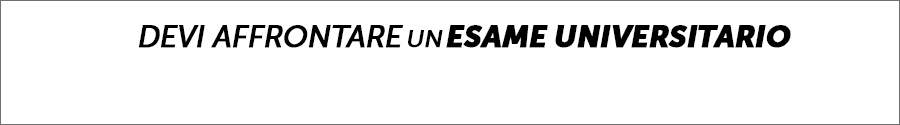
Legalità
Legalit
Principio in virt
Nella dottrina contemporanea il principio viene inteso in diverse accezioni:
— gli atti dei pubblici poteri (provvedimenti puntuali e concreti, atti normativi del potere esecutivo, sentenze) non possono contenere disposizioni in contrasto con la legge. Si parla, in tal caso, di una preferenza della legge o di supremazia della legge rispetto agli atti dei poteri esecutivo e giurisdizionale;
— gli atti dei pubblici poteri devono trovare il loro fondamento positivo, devono essere autorizzati dalla legge. Si parla, in tal caso, di (—) in senso formale;
— gli atti dei pubblici poteri devono essere disciplinati compiutamente dalla legge. Si parla, in tal caso, di (—) in senso sostanziale.
La prima accezione del principio di (—) segn
Nel nostro ordinamento positivo, il principio della preferenza di legge trova riscontro, per quanto riguarda gli atti giurisdizionali, nell'art. 111, co. 7 Cost., in base al quale contro le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali [Giudice (ordinario); Giudice (speciale)]
Il principio di (—) in senso sostanziale
I riferimenti fatti ai sistemi a Costituzione rigida consentono di precisare che nel nostro ordinamento il principio di (—) finisce per condizionare non solo il potere esecutivo e quello giurisdizionale, ma anche quello legislativo. In base all'art. 134 Cost., infatti, la legge ordinaria [Legge] non pu
(—) nel diritto amministrativo (d. amm.)
Il principio di (—) afferma la corrispondenza dell'attivit
Il principio di (—) pu
— in senso debolissimo, pu
— in senso debole,
— in senso forte,
La (—) sostanziale implica che il legislatore debba disciplinare compiutamente i pubblici poteri e in tal modo esso si sovrappone all'istituto della riserva di legge, sia essa assoluta o relativa. Nelle materie non coperte da riserva (peraltro assai rare), il principio di (—) si atteggia in senso formale come necessit
La dottrina ha ricercato un fondamento positivo al principio di (—), talvolta ritenendolo implicito nelle numerose riserve di legge disseminate nella Costituzione (artt. 13 ss., art. 23): in particolare, tale principio si ricaverebbe dall'art. 97 Cost. il quale, stabilendo che l'organizzazione dei pubblici uffici segue le disposizioni di legge, porrebbe la legge su una posizione di supremazia rispetto all'attivit
Secondo altri autori il principio si ricaverebbe dagli artt. 24 e 113, che sanciscono il controllo del giudice sull'attivit
Secondo Fois, la norma costituzionale che implicitamente stabilisce il principio di (—) dell'azione amministrativa
La P.A., pertanto, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, non pu
Conseguenze di questo principio - richiamato dallo stesso art. 1 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, ove si statuisce che l'attivit
— la tipicit
— l'eccezionalit
— l'eccezionalit
(—) nel diritto penale (d. pen.)
Principio generale del diritto penale che importa il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della commissione, non sia espressamente previsto come reato e di sanzionarlo con pene che non siano dalla legge espressamente previste (art. 25 Cost.; art. 1 c.p.) Il nostro ordinamento adotta, dunque, il principio di (—) formale tipico degli ordinamenti democratici, a differenza della (—) sostanziale, secondo la quale costituisce reato qualunque fatto socialmente pericoloso, anche se non previsto dalla legge.
Se, infatti, il principio di (—) sostanziale consente una pi
Il principio di (—) si scompone nei seguenti fondamentali corollari:
— il principio della riserva di legge in materia penale, che comporta il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo configuri come reato;
— il principio nulla poena sine lege, in forza del quale il tipo e la durata (tra un limite minimo e un limite massimo) della pena da irrogare per ogni fattispecie di reato devono essere sempre predeterminati dalla legge;
— il principio di tassativit
— il principio di irretroattivit
— il divieto di analogia in materia penale.