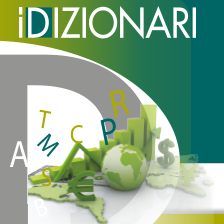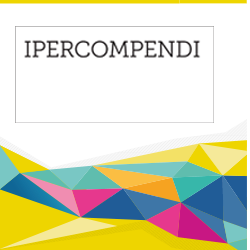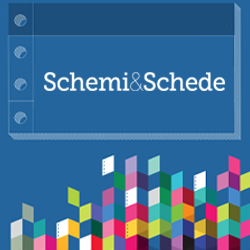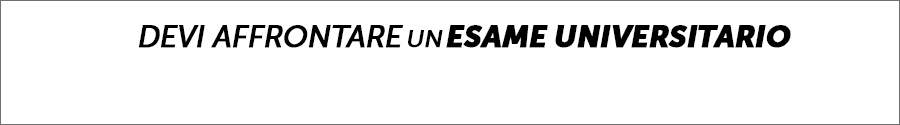
Gestione
Gestione
(—) accentrata di strumenti finanziari (d. finanz.)
(—) collettiva di portafoglio (d. finanz.)
Con tale espressione si indica l'attivit
Tale servizio finanziario si realizza attraverso:
— la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
— la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento o di SICAV, di propria o di terza istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
L'esercizio dell'attivit
(—) d'affari (d. civ.)
Si ha (—) quando un soggetto (gestore) si prende cura spontaneamente, cio
Requisiti della (—) sono:
— l'utilit
— la mancanza di un divieto alla (—) da parte del dominus (
— la consapevolezza dell'alienit
— la liceit
— la capacit
La (—) produce effetti:
— nei confronti del gestore, che ha l'obbligo di continuare la gestione intrapresa, finch
— nei confronti del dominus, che deve adempiere, verso i terzi, agli obblighi che gli derivano dai negozi compiuti dal gestore in suo nome [(—) rappresentativa] e deve tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi abbia assunto in nome proprio [(—) non rappresentativa], rimborsandogli le spese sostenute ed i relativi interessi. Da ci