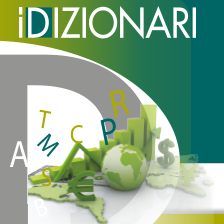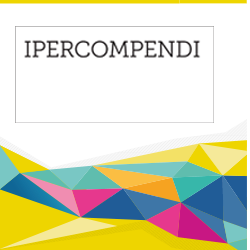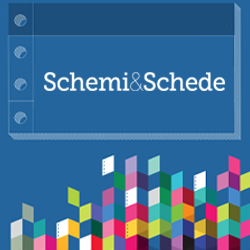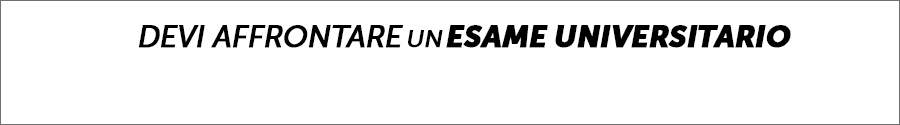
Winnicott, Donald
Winnicott, Donald
Pediatra e psicoanalista inglese (Plymouth, Devon, 1896 - Londra, 1971), figura di grande rilievo della psicoanalisi europea, mantiene tuttavia una precisa autonomia e una certa indipendenza, grazie ad una stretta connessione tra pratica clinica ed elaborazione concettuale. A contatto inizialmente con Melanie Klein (da cui fu analizzato), successivamente si discosta dal suo pensiero divenendo entrando nel cosiddetto gruppo degli